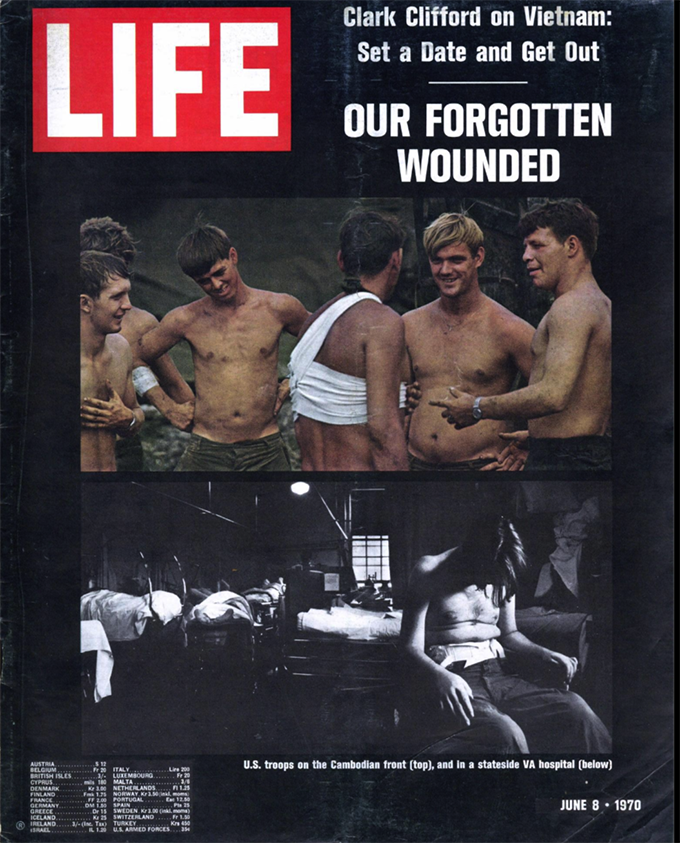Da Cultura Commestibile, n° 85, PAG.7, sabato 19 luglio 2014
Fra certi esseri umani e certi luoghi esistono dei rapporti che spesso vanno oltre il senso di appartenenza o di identificazione, e che li rendono in qualche modo complementari fra di loro. Così si formano dei binomi che appaiono inscindibili, fra personaggi dotati di forte personalità, acuta sensibilità e profonda cultura e luoghi, spesso intere città, che appaiono cristallizzati nelle visioni che tali personaggi ne hanno offerto.
Molti autori si legano in maniera inscindibile ai luoghi descritti nelle loro opere, sia pittoriche che letterarie, tanto che non appare possibile evocare i primi senza evocare nello stesso tempo i secondi. Questo rapporto appare forse ancora più chiaro nell’opera dei fotografi, per i quali non esistono scorciatoie o licenze poetiche. Contrariamente agli scrittori ed ai pittori, i fotografi non raffigurano città ideali o luoghi immaginari, più o meno trasfigurati dalla fantasia ed appannati dal ricordo, ma città e luoghi profondamente reali, dove la luce è l’unica variabile possibile e la scelta del momento della ripresa è l’unica alternativa concessa.
Di queste “liaisons” fra fotografi e città se ne potrebbero citare a dozzine, partendo ad esempio da Atget. Cosa sarebbe Atget senza Parigi, e come sarebbe Parigi senza Atget? Ma forse un esempio an- cora più stringente, anche se meno noto, è rappresentato da Praga e dal suo fotografo Josef Sudek (1896-1975). Orfano di padre fino dall’età di tre anni, il quattordicenne Josef Sudek arriva a Praga nel 1910 per diventare rilegatore, comincia a fotografare nel 1913 per passione e parte per la Grande Guerra con la sua fotocamera, ritornandone nel 1916 mutilato e privo del braccio destro.
Diventa quindi fotografo professionista, frequenta l’ambiente culturale ancora in parte dominato dal pittorialismo, ma già aperto allo spirito delle avanguardie, ed arriva ad aprire un proprio studio nel 1927, collaborando in seguito con una casa editrice. Come Atget (ma il parallelo è del tutto casuale) predilige i grandi formati, che lo aiutano a catturare la nitidezza assoluta e le inquadrature rigorose, ed ai ritratti che esegue per lavoro associa tutta una serie di ricerche personali.
Il secondo conflitto mondiale e l’occupazione nazista, seguita dalla invadente presenza sovietica, lo spingono a confinarsi nelle sue stanze, dove approfondisce il rapporto intimo con le cose che lo circondano, gli oggetti quotidiani, gli scorci ripresi dalla finestra, il piccolo mondo tranquillo che diventa ai suoi occhi un microcosmo ricco di occasioni. Sudek incontra se stesso, il suo io più profondo, in una maturazione obbligata che rende le sue immagini universali, proprio perché prive di qualsiasi forma di retorica, formalismo o pretesa estetica ed artistica.
Le sue immagini sono tranquille, meditate, forti, essenziali, nella loro apparente semplicità sono lontanissime dalla banalità, sono lo specchio di un rapporto profondo fra le cose e la loro percezione. L’isolamento di Sudek non gli impedisce di continuare a fotografare la sua città, percorrendola a piedi con la pesante fotocamera sulle spalle, e di fotografarla in maniera forse ancora più coerente e cosciente di prima, meno attento agli aspetti più folcloristici, più sensibile e curioso dei particolari e dell’essenza delle cose. La Praga magica di Sudek non è quella letteraria di Kafka e non è neppure quella cantata da altri poeti, è una cosa profondamente diversa.
Si potrebbe quasi dire che Praga è Sudek, e che Sudek è Praga.